|
 L'arredamento ed i servizi di casa negli anni
Trenta
L'arredamento ed i servizi di casa negli anni
Trenta
L’arredamento della casa contadina era semplice e uguale per
tutti: letti formati da assi di legno su cavalletti, con
pagliericci di foglie di granoturco o materassi di piume e di
lana grezza, credenze di buona e solida fattura artigiana,
cassepanche, una madia per la farina e il pane, poche sedie
impagliate, parecchie immagini di santi. Nelle famiglie operaie
la stanza da pranzo si chiamava «salotto», il divano aveva la
trina bianca alla spalliera, il letto era di legno lucido, con
decorazioni d’ottone e la rete metallica, con un crocifisso o la
Madonna col bambino inchiodato al capo del letto, un ramoscello
d’ulivo benedetto la Domenica delle Palme per traverso, il comò
o canterano con la grande sveglia a suoneria, lumi a petrolio o
acetilene dalla combustione di carburo e acqua, quando la
corrente elettrica non c’era, specchi appesi al muro. Eppoi foto
di famiglia: il ritratto pittorico, destinato per i posteri è
riservato ai ceti più abbienti. Quello fotografico è alla
portata di tutti o quasi. Il telefono di casa pochi ce l’hanno,
pochi lo usano, è in bachelite nera e in famiglia si applica al
muro. A metà degli anni Trenta in Toscana gli abbonati alla Teti
(la Telefonica tirrenica) erano qualche migliaio. Il servizio
telefonico italiano era vantato come uno dei migliori del mondo,
crediamoci. Nel 1931, l’88 per cento delle case italiane non
aveva il «gabinetto di decenza», come si diceva nel linguaggio
comune; raramente e solo in paese i servizi igienici in comune
nel ballatoio o in cortile, e d’inverno, quando la temperatura
si faceva rigida, era particolarmente disagevole fare la coda
per aspettare il proprio turno. Era fortunato chi aveva in casa
o sul terrazzo un bugigattolo adibito a gabinetto, che i vecchi
toscani chiamavano pudicamente «licite», consistente in una buca
alla turca e un secchio d’acqua
(Vedi). La
carta igienica non aveva grande commercio; appesi a un gancio
c’erano pezzi di giornale e quasi mai il lavandino per lavarsi
le mani.
Furono gli inglesi a introdurre nel continente il «water
closet», sciacquone su vaso di maiolica, con l’uso dell’acqua
corrente nel gabinetto. A Genova dove grazie al porto,
arrivarono i primi, il vaso di ceramica veniva messo in cucina,
ma con accanto un secchio di acqua dove mancava l'acquedotto.
All’inizio in Italia non ebbe molta fortuna, anche perché
fino a dopo la II
Guerra Mondiale,
poche case avevano l’acqua
corrente. Quella necessaria alla famiglia bisognava ancora, come
sempre era stato, attingerla al pozzo e alla fonte pubblica con
le brocche di rame che le donne anziane vestite di nero
portavano in equilibrio sulla testa,
quindi un bene prezioso da usare con parsimonia estrema.
In campagna era una necessità meno impellente, bastava scendere
presto al mattino e scegliersi un luogo appartato: c’era l’uso
di scavare "fosse biologiche" e metterci di traverso qualche
tavola di legno. Anche nelle case dei benestanti le vasche da
bagno erano una rarità, in lamiera porcellanata con quattro
zampe costava 200-300 lire, il concetto dell’igiene era ancora
molto relativo, il bagno si faceva la domenica nel migliore dei
casi. Ci si lavava in fretta, con un grosso pezzo di sapone
fatto in casa, non al mattino, ma la sera per sfruttare
d’inverno il tepore della casa, stando in piedi nella tinozza
zincata o di cotto, mai un bagno completo. Gli apparecchi da
bagno, dapprima quasi tenuti nascosti come indecenti e di
cattivo gusto, alla fine degli anni Trenta divennero essenziali
per una migliore abitabilità e igiene della casa con la nuova
definizione di «sanitari». Il bidet o «bidello», come veniva
chiamato, lo possedevano in pochissimi e non le persone
morigerate. Il bidet, inventato dai francesi e usato
prevalentemente nei paesi cattolici, era quasi sconosciuto nel
Nord Europa, e lo è tuttora in Gran Bretagna, dove l’abitudine
del bagno completo al mattino rendeva secondo loro, inutile
l’uso di quello strano oggetto per «abluzioni locali». La
borghesia fascista lo tollerava come strumento adatto alle
persone malate, come il «pappagallo» per chi non poteva alzarsi
dal letto. Chi cedeva alla tentazione, lo faceva quasi di
soppiatto e vergognandosene. Per i benpensanti era un’offesa al
pudore e le signore, e in particolar modo le fanciulle
innocenti, avrebbero fatto bene a non servirsene. Le parti
intime del corpo si continuavano a chiamare le «vergogne», e non
bisognava esibirle in modo inverecondo a cavallo di
quell’oggetto ripugnante.
La casa borghese
era sicuramente più grande e confortevole, con molti locali,
saloni destinati ai ricevimenti e alle feste, mobili d’epoca,
soprammobili e suppellettili di pregio, quadri d’autore alle
pareti, ma anche i signori d’inverno erano costretti a passare
parte della loro giornata nelle uniche stanze riscaldate dal
camino, mentre il resto della casa era una ghiacciaia. Si gelava
anche nel gabinetto, che era sempre esposto nei punti più
periferici e freddi della casa; ma almeno i signori avevano il
privilegio della privacy sconosciuta nelle famiglie povere che
vivevano in assoluta promiscuità. Nelle notti d’inverno si
andava a letto con lo scaldino. Il più comune era in terracotta
o rame, col manico a ponte, di media grandezza, com’è descritto
nel vocabolario dell’uso toscano di Pietro Fanfani del 1865. Lo
scaldino conteneva la brace accesa, coperta di cenere perché non
si consumasse troppo in fretta e non bruciasse le lenzuola, e lo
si agganciava dentro un’intelaiatura di legno a forma ovale o
circolare collocata sotto le coperte. Lo si metteva nel letto
dei vecchi e dei più piccoli quando il clima era particolarmente
rigido e le lenzuola sembravano di ghiaccio. Quello ovale, in
Toscana,
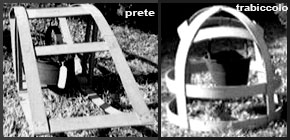 si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte
aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante
il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la
luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle
campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero
carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle
stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di
possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio
enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua
apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo
1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:
l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe
sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi
occasioni la parola dei Duce diffusa
dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei
villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel
1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla
ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno
foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per
strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una
bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si
facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio
pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa
avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli
angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un
catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si
teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e
immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940
la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le
colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di
tipo sigillato, venduto come «il più grande successo
dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un
lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di
famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la
pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero
senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo
odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione
della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle
case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la
grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel
pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla
macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In
ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con
qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,
costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,
perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le
bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,
si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei
pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su
entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a
destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.
Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a
manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con
motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo
l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci
accompagna da oltre mezzo secolo.
(Sintesi da: "Otto milioni di biciclette" di Romano Bracalini) si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte
aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante
il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la
luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle
campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero
carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle
stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di
possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio
enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua
apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo
1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:
l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe
sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi
occasioni la parola dei Duce diffusa
dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei
villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel
1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla
ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno
foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per
strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una
bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si
facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio
pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa
avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli
angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un
catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si
teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e
immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940
la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le
colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di
tipo sigillato, venduto come «il più grande successo
dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un
lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di
famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la
pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero
senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo
odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione
della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle
case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la
grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel
pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla
macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In
ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con
qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,
costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,
perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le
bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,
si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei
pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su
entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a
destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.
Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a
manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con
motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo
l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci
accompagna da oltre mezzo secolo.
(Sintesi da: "Otto milioni di biciclette" di Romano Bracalini)
Come eravamo…Ricordi di una nonna
La vita di tutti i giorni quando ero bambina e poi ragazza, era
molto semplice e piuttosto dura. Nelle case non c’era il
riscaldamento e nell’inverno l’unica stanza riscaldata era la
cucina con il camino o con una stufa economica ed ambedue
venivano alimentate con la legna. La stufa aveva dei cerchi di
ferro che si potevano levare per mettere sul fuoco la pentola o
il tegame, a sinistra c’era una piccola vasca per avere a
disposizione un po’ di acqua calda, attaccati al tubo c’erano
dei ferri per asciugare piccoli capi di biancheria. Chi non
possedeva questo tipo di cucina aveva due cavità nel camino che
contenevano i fornelli di ghisa per accendere il fuoco.
Accendere il fuoco era un’impresa piuttosto noiosa. Nel fornello
si mettevano prima dei fogli, poi la brace e si dava fuoco,
quando la brace era accesa si aggiungeva il carbone e si
sventagliava per una completa accensione. Qualche volta i tizzi
del carbone non erano cotti bene e facevano un gran fumo. Sopra
al camino c’erano la ventaglia, la paletta e le molle. Per
accendere il fuoco le mani diventavano nere. Brace e carbone si
compravano dal carbonaio. Attaccata in cucina c’era la
moscaiola.
Il gabinetto era situato in una piccola stanza con una
finestrina; rialzata dal terreno c’era una pietra di marmo con
una buca e un tappo di legno. La carta igienica non esisteva,
attaccati ad un chiodo o messi in una borsina c’erano dei fogli
di giornale che macchiavano di stampa il sedere. Spesso nei
condomini questi gabinetti erano per le scale e servivano per
più famiglie. Da casa mia vedevo il dietro di alcune abitazioni
del vicolo del Berti, qualche famiglia aveva fuori dalla
finestra un grosso tubo di terracotta con un tappo; questo era
il suo servizio igienico. I vecchi chiamavano “licite” il
gabinetto. I dipendenti Solvay che abitavano nelle case della
società, erano più fortunati, avevano i gabinetti alla turca. Ci
si lavava nell’acquaio della cucina, a volte andavamo ai bagni
pubblici. Non c’era l’acqua corrente in casa, bisognava
rifornirsi alla fonte con mezzine di rame, secchi e brocche. Il
bucato veniva fatto ai lavatoi comunali. Noi avevamo le pile nei
fondi ed il bucato veniva fatto con acqua bollente e cenere. Il
liquido che usciva si chiamava”ranno” e serviva anche per
lavarsi i capelli che si asciugavano al sole. Spesso per
pettinarsi si usava il pettine fitto. Mi viene in mente un altro
ricordo: nell’inverno per scaldarci durante il giorno si usavano
gli “scaldini” chiamati anche “caldani” con dentro brace accesa
e cenere; per tenere caldi i piedi li mettevamo in terra vicino
alle gambe, per scaldarci le mani, li tenevamo sulle ginocchia.
La sera per trovare il letto caldo, mettevamo sotto le coperte
il “trabiccolo” formato da assi di legno con un gancio in alto
nel centro per attaccarci lo scaldino. Nonostante questi mezzi,
pativamo molto freddo e ci venivano i geloni alle dita dei piedi
e delle mani. Questi arrossamenti erano dolorosi.
Il “trabiccolo” era un
fuso rettangolare e scaldava il letto a
due piazze, il “prete” era più piccolo e a cupola e scaldava il
lettino. Quando il bambino si ammalava, non si chiamava subito
il dottore, si pensava che avesse l’indigestione e la sera gli
veniva data una bella purga. La mattina doveva bere una tazza di
brodo caldo per farla agire meglio. Ai miei tempi non sarebbe
servita la ciclette, perché per andare a lavoro, alle scuole
medie, al mare, al cinema si andava tutti a piedi o in
bicicletta. La mattina presto e la sera alle 17, un lungo fiume
di tute azzurre si snodava lungo le strade, erano gli operai
della Solvay che tornavano ai loro paesi sulle colline,
Rosignano M.mo, Castelnuovo, Gabbro, Nibbiaia. Gli operai
fermavano il fondo dei pantaloni con i gancini dei panni, perché
non andassero nei raggi della ruota o si sporcassero alla
catena. Io tornavo a casa dalle mie girate, a quest’ora per
viaggiare in compagnia. Gli uomini mettevano sul petto dentro la
tuta, dei fogli di giornale per ripararsi dal freddo che
penetrava dai vestiti. A quei tempi la bicicletta era un bene
prezioso. Quando, oggi, vedo passare per le strade le donne con
abiti con le punte, con la coda dietro o sui fianchi, ripenso
con un sorriso a quando la mia mamma mi metteva ritta sul tavolo
di cucina e con il metro di legno prendeva le misure per un orlo
perfetto, non doveva pendere nemmeno di un centimetro. Io mi
annoiavo a stare diritta e girare lentamente.
Andavamo a prendere il
latte alla latteria con la nostra bottiglia o con il bollilatte.
Le misure erano: un quartino, mezzo litro e il litro. Nei negozi
di alimentari la spesa veniva incartata con carta gialla o con
carta impermeabile, l’olio si vendeva sfuso e occorreva portare
la bottiglia. Non esistevano i frigoriferi, il burro si
conservava con l’acqua nella burriera, brodo, frutta, acqua per
renderla fresca si conservava in un secchio appeso nel pozzo.
Quando un secchio cadeva nel pozzo si cercava di riprenderlo con
un rampino. Ricordo che al mio bar qualche donna veniva a
chiedere i fondi del caffè per adoperarli per la colazione della
mattina. Spesso a casa mia veniva Agatina, una donna che abitava
in castello, a prendere vestiti usati. Gli orti venivano
concimati con il liquame, preso con il mescino, dal pozzo nero
(che igiene!)
Le piante erano concimate
con la pollina e con lo sterco dei cavalli. Non usavamo gli
insetticidi, si dava il “flitte” con una macchinetta e nelle
cucine, al camino veniva appesa una lunga striscia arricciolata
intrisa di colla; gli insetti si avvicinavano e ci rimanevano
attaccati. Nelle botteghe di alimentari, ad una parete c’era un
mobile con tanti cassetti con la parte esterna di vetro, dentro
a questi contenitori erano in mostra le varie qualità di pasta.
In terra c’erano molti sacchi che contenevano riso, zucchero,
ceci e fagioli, tutto veniva preso con mestole e pesato sulla
stadera in fogli di carta gialla. Quando ero giovane le donne
non portavano i pantaloni, le gonne dovevano essere sotto il
ginocchio, le scollature erano alte perché non si doveva vedere
il seno. Non usavano le calzamaglie, si portavano i calzettoni
che riparavano poco dal freddo. Le calze di nailon vennero sul
mercato verso il 1950 e quando si smagliavano si portavano da
Iris che le accomodava con un piccolo uncinetto elettrico.
Dopo il passaggio del
fronte (1944), cappotti e giacche si facevano con le coperte dei
soldati americani e le camicette venivano confezionate con la
seta dei paracaduti, sempre americani.
Le merende dei nostri
tempi erano: una fetta di pane bagnata nell’acqua e poi cosparsa
di zucchero, oppure bagnata nel vino e poi sopra lo zucchero.
Più saporita era la fetta strusciata con il pomodoro, sale e
olio. A volte sulla fetta di pane veniva messo un po’ di olio e
sale o marmellata o miele. A me piaceva prendere il cantuccio
del pane, toglierci la mollica e nella buchetta metterci olio e
sale; qualche volta lo faccio ancora e provo molto gusto come
quando ero piccola.
Verso il 1955 una
trasmissione televisiva “Lascia o raddoppia?” condotta da M.
Bongiorno divenne un fenomeno nazionale. Non tutte le famiglie
avevano il televisore, così tutti i giovedì (giorno del
programma) andavamo dai vicini o al bar. In quel giorno i cinema
erano deserti, perciò i gestori si attrezzarono e installarono
nelle sale vari televisori e la gente prima vedeva “Lascia o
raddoppia?” e poi il film. Questo programma era avvincente
perché si basava sulla preparazione e sulla memoria dei
concorrenti ed inoltre il premio finale era di 5 milioni, una
cifra molto alta per quei tempi. Da: "Come
eravamo..." di Anna Maria Raigi scaricabile dal sito. |
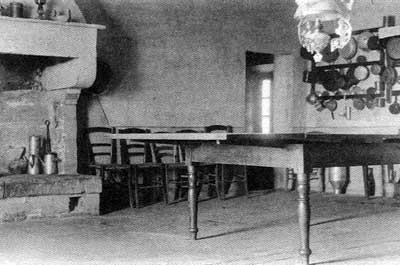
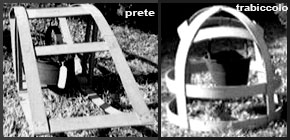 si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte
aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante
il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la
luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle
campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero
carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle
stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di
possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio
enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua
apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo
1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:
l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe
sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi
occasioni la parola dei Duce diffusa
dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei
villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel
1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla
ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno
foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per
strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una
bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si
facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio
pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa
avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli
angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un
catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si
teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e
immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940
la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le
colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di
tipo sigillato, venduto come «il più grande successo
dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un
lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di
famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la
pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero
senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo
odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione
della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle
case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la
grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel
pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla
macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In
ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con
qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,
costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,
perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le
bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,
si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei
pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su
entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a
destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.
Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a
manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con
motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo
l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci
accompagna da oltre mezzo secolo.
si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte
aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante
il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la
luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle
campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero
carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle
stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di
possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio
enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua
apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo
1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:
l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe
sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi
occasioni la parola dei Duce diffusa
dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei
villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel
1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla
ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno
foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per
strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una
bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si
facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio
pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa
avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli
angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un
catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si
teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e
immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940
la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le
colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di
tipo sigillato, venduto come «il più grande successo
dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un
lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di
famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la
pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero
senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo
odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione
della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle
case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la
grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel
pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla
macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In
ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con
qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,
costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,
perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le
bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,
si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei
pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su
entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a
destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.
Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a
manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con
motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo
l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci
accompagna da oltre mezzo secolo.